a cura di Maria Nadotti
Responsabile dell’Unità di salute mentale presso il Ministero della salute palestinese e professoressa associata di Psichiatria e Scienze Comportamentali presso la George Washington University di Washington DC, Samah Jabr si occupa di formazione e supervisione con un’attenzione particolare alla Terapia Cognitivo Comportamentale (CBT). Contribuisce alla mhGAP (Mental Health Gap Action Programme guideline dell’Organizzazione mondiale della sanità) che offre indicazioni, raccomandazioni e aggiornamenti per il trattamento di disturbi mentali, neurologici e abuso di sostanze e al Protocollo di Istanbul per la documentazione della tortura.
Maria Nadotti: Dal 2016 lei è a capo dell’Unità di salute mentale presso il Ministero della salute palestinese. A lei e ai suoi colleghi sono affidate la Cisgiordania e Gerusalemme Est e, almeno sulla carta, Gaza. Come si cura o si tenta di lenire la sofferenza psichica in un contesto coloniale esploso come quello dei Territori occupati di Palestina? Quali sono le difficoltà maggiori e gli ostacoli più insidiosi nello svolgimento della sua funzione?
Samah Jabr: Innanzitutto siamo pochissimi, mentre la gravità della situazione richiederebbe forze di cui non disponiamo. La mia giornata inizia prestissimo: fino alle tre del pomeriggio svolgo un lavoro di pianificazione presso il Ministero, mentre nel pomeriggio mi occupo dei miei pazienti, che spesso non è facile raggiungere. A Gaza, dal marzo del 2023, non sono più riuscita a entrare. Ciò significa che devo affidarmi alle consultazioni e alla formazione a distanza, sperare nella tenuta di internet e augurarmi che la fornitura di energia elettrica non venga interrotta. Difficile del resto muoversi anche in Cisgiordania, per non parlare di quanto sia complicato uscire dal paese. Benché io goda dello status relativamente privilegiato dei palestinesi che risiedono a Gerusalemme e la mia professione mi consenta una certa mobilità, il sistemico furto di tempo e di energie vigente nel paese non risparmia nessuno. Per andare all’estero sono autorizzata a servirmi dell’aeroporto di Tel Aviv, ma ogni volta devo certificare lo scopo ‘scientifico’ del mio viaggio. Ad esempio, per raggiungervi in Italia dove è appena uscito un mio nuovo libro, ho dovuto sfruttare un convegno psichiatrico che si è svolto ad Atene. Non mi avrebbero autorizzata a uscire dal paese per presentare una raccolta d scritti intitolata Il tempo del genocidio. Rendere testimonianza di un anno in Palestina.
MN: E sul piano della clinica?
SJ: Va fatta una premessa. In un contesto politico e sociale come quello in cui i palestinesi vivono da oltre un secolo e che ha avuto precise tappe storiche che si sono impresse nella memoria collettiva trasmettendosi da una generazione all’altra, la sofferenza psichica si esprime attraverso sintomi ferocemente individuali, ma non può essere trattata come un problema della singola persona. È l’atmosfera traumatogena in cui viviamo a produrre il disagio psichico ed è dunque in rapporto a questa situazione che dobbiamo elaborare interventi, pratiche, modalità di ascolto che ci permettano di riparare almeno un po’ la lacerazione cui soprattutto bambine, bambini e donne vengono esposti quotidianamente in forma sempre più brutale.
MN: Quali sono le tappe storiche che sono andate a incidersi più in profondità nella memoria intergenerazionale dei palestinesi?
SJ: All’origine di tutto c’è la Dichiarazione Balfour del 1917. In una lettera indirizzata a Lord Rothschild, rappresentante della comunità ebraica inglese e referente del movimento sionista, l’allora ministro degli esteri del Regno Unito Arthur Balfour affermò che il governo del Regno Unito guardava con favore alla creazione di un “focolare nazionale per il popolo ebraico” in Palestina, che all’epoca faceva ancora parte dell’Impero ottomano. Da allora l’espropriazione territoriale che culminerà nella Nakba del 1948 con l’esodo forzato di oltre settecentomila arabi palestinesi non si è più interrotta. Gaza, a seguito della “guerra dei sei giorni” del 1967, si è trasformata in un enorme campo profughi. Migliaia di palestinesi vi sono approdati dopo essersi visti portare via per la seconda volta casa, terra, beni, memorie e identità. Su su fino alla situazione attuale: a Gaza è in corso da oltre un anno qualcosa che non è appropriato definire una guerra e in Cisgiordania e a Gerusalemme Est le colonie di insediamento israeliane stanno crescendo a ritmi tumultuosi e con esse la violenza esercitata sulla popolazione palestinese.
MN: Quindi un accumulo di esperienze traumatiche, uno stratificarsi della precarietà, una provvisorietà fattasi permanente.
SJ: Precisamente. Anche un incidente automobilistico è un trauma, ma a produrlo è un evento preciso, istantaneo, riconoscibile. Il trauma inscritto nell’esperienza dei palestinesi è reiterato, costante, subdolo. Si accumula, dunque può trasmettersi come un’‘eredità’. Se non lo si riporta alla sua genesi storico-politica, se non lo si affronta come trauma di un’intera società, non se ne viene a capo. Non si possono curare con i farmaci o con la psicoterapia individuale il lutto di una madre che si è vista uccidere un figlio o i disturbi dell’alimentazione o dell’attenzione di bambini esposti all’umiliazione e alla svirilizzazione continua della figura paterna. Se non si trova modo di arrivare alla causa e al cuore di quella sofferenza, di permetterle di esprimersi offrendole il tempo e l’amorosità dell’ascolto e della comprensione, si rischia solo di iperpatologizzarla. In una situazione come la nostra, chi soffre non va messo nella posizione del ‘paziente’, ma affiancato nella ricostituzione di un tessuto sociale che si è smagliato e che rischia di non ricomporsi mai più. Ed è un lavoro eminentemente politico.
MN: Se in Palestina non esiste il disturbo post-traumatico perché il trauma è continuo, in base alla sua esperienza come possono essere trattati i traumi in corso?
SJ: Il trauma palestinese è coloniale, deliberato, ripetitivo, cumulativo e transgenerazionale. Come ci hanno insegnato Frantz Fanon, Nelson Mandela, Ignacio Martín-Baró a essere patogeno è il dispositivo politico dell’occupazione e dell’apartheid. È l’esposizione incessante alla violenza, alla vessazione, all’umiliazione a deformare la psiche degli individui, costretti ad adattarsi al peggio per sopravvivere. Il progetto coloniale è, in sostanza, la riduzione dell’individuo all’impotenza. E cosa c’è di meglio che traumatizzare le persone per ridurle all’impotenza? Si tratta di una strategia. A essa possiamo reagire solo dotandoci – tanto noi terapeuti e formatori quanto le persone che si affidano alle nostre cure – di strumenti di consapevolezza in grado di sostenerci. Quello che la società palestinese subisce da oltre un secolo è un trauma intenzionale e capillare, diretto e indiretto. Ecco perché tutte e tutti possono contribuire a fermarlo. Da noi i professionisti della salute mentale non possono fare un buon lavoro clinico se non sanno creare politiche pubbliche capaci di dare risposta a situazioni di crisi.
MN: Può dirci come è cambiato il vostro modo di operare nel corso dell’ultimo anno?
SJ: A Gaza, prima dell’attacco militare su larga scala in corso dall’ottobre del 2023, avevamo sette centri psichiatrici autorizzati – solo sette per 2,4 milioni di persone – e un numero maggiore di psicologi clinici. Avevano un ospedale psichiatrico in grado di accogliere quarantacinque pazienti e sei ospedali comunitari per la salute mentale. Il modo in cui lavoriamo in Palestina è più focalizzato sulla psicologia di comunità, dove cerchiamo di non fare troppo affidamento sulle strutture psichiatriche, ma incoraggiamo un programma di integrazione della salute mentale con le cure primarie. Ad esempio, incoraggiamo un programma scolastico di salute mentale in modo da ridurre al minimo la necessità di recarsi in una clinica psichiatrica specializzata. Poiché ci sono pochi professionisti specializzati in salute mentale, facciamo molto affidamento su altre figure, medici, infermieri, insegnanti, consulenti e talvolta leader religiosi, che possono svolgere un ruolo importante nella prevenzione dei problemi di suicidio e di abuso di sostanze. Questo era il sistema prima dell’attacco. Nel giro del primo mese cinque centri psichiatrici su sette sono stati distrutti e l’unico ospedale psichiatrico, che si prendeva cura di quindicimila pazienti psichiatrici gravi, è stato completamente danneggiato. Le persone che dipendevano da questa struttura, da questo centro governativo, sono rimaste senza farmaci e senza assistenza.
MN: Che cosa può fare, in una situazione simile, il curante?
SJ: Tenere ben saldo il senso della responsabilità morale. Il ruolo di psichiatra e psicoterapeuta ti mette in una relazione molto intima con le persone che si rivolgono a te, diventi testimone della loro storia e, attraverso l’ascolto, le aiuti a darle un senso. Qualche esempio. Una madre di Gerusalemme si rivolge a me chiedendomi dei farmaci per il figlio dodicenne che, a detta degli insegnanti, soffre di un grave disturbo dell’attenzione e crea problemi in classe. Parlando con il ragazzino, dandogli il tempo della mia attenzione, scopro che alla scuola che frequenta è stato imposto il curriculum scolastico israeliano pena la perdita dei finanziamenti pubblici. Lui quell’imposizione non l’ha accettata, ma la madre non gli ha permesso di cambiare scuola. Non vuole che il figlio debba affrontare il sistema dei check point per raggiungere un istituto in Cisgiordania. E così lui ha adottato la strategia della disattenzione per dire non il suo disagio psichico, ma la sua rivolta. La mia ‘terapia’ è consistita nell’orientarlo verso il buon uso della sua ribellione: sfruttare la situazione per studiare bene il curriculum scolastico israeliano, mettendolo a confronto con quello adottato in Cisgiordania. Interrogare, capire, spiegare. Il contrario del subire in silenzio. Diventare attivi. Farsi agenti della propria storia. Il sumud palestinese, un misto di tenacia, resistenza non passiva, iniziativa, è proprio questo.
O ancora: in Cisgiordania negli ultimi mesi c’è stata una crescita esponenziale dei disturbi dell’alimentazione tra i giovanissimi. I bambini perdono vistosamente peso e rifiutano di mangiare. In Occidente lo si interpreterebbe e tratterebbe come un problema legato all’immagine di sé. Da noi, se ci si dà il tempo di ascoltare, si scopre tutt’altro. La sofferenza e l’acting out del digiuno nascono da ciò che sanno, sentono e vedono di ciò che accade a Gaza. Una mia piccola paziente non mangia, ma accumula cibo in scatola e bottiglie d’acqua in vista di quello che potrebbe succedere anche in Cisgiordania. Un altro non riesce a ingoiare il cibo, perché ha saputo che gli abitanti di Gaza ridotti alla fame sono stati costretti a mescolare foraggio per animali alla farina per il pane. Non possiamo fare molto per togliere quelle immagini dai loro occhi e dalla loro coscienza, ma insieme a loro, con delicatezza e attenzione, possiamo provare a ridurre la morsa del trauma. Spesso basta un gioco, una piccola attività, un minuscolo non prescritto fare per rimettere in moto la speranza, che è il principio fondamentale della vita.
Un’altra piccola storia: un adolescente di Gaza, sfollato insieme alla famiglia e costretto a vivere in una tenda, è soggetto a enuresi notturna. Ogni mattina la madre stende ad asciugare la sua biancheria intima, esponendolo alla bullizzazione dei suoi coetanei. Quel ludibrio è il suo personale genocidio. Basterebbe, da parte della famiglia, una maggiore sensibilità, un piccolo gesto in grado di proteggere il pudore del figlio.
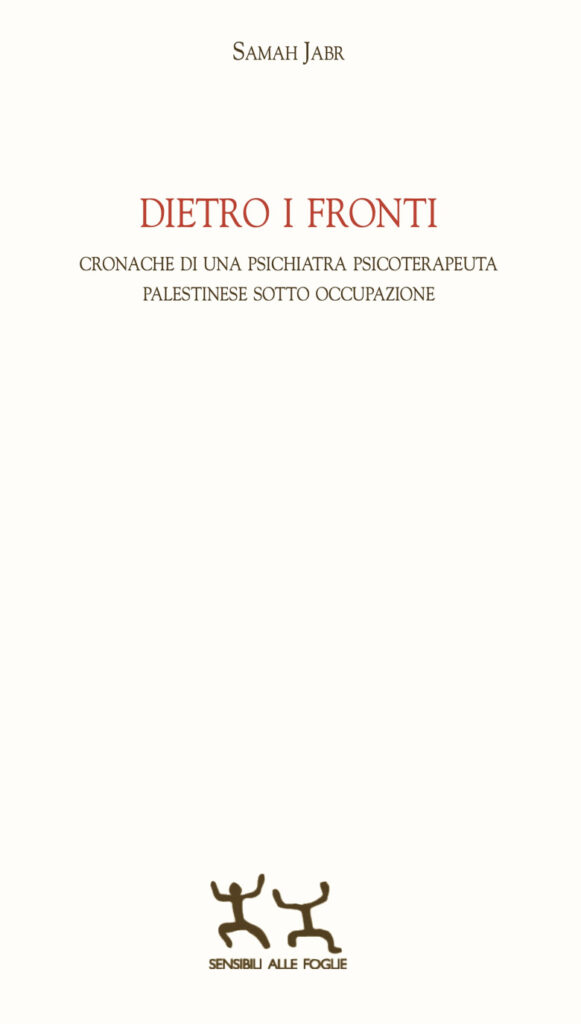
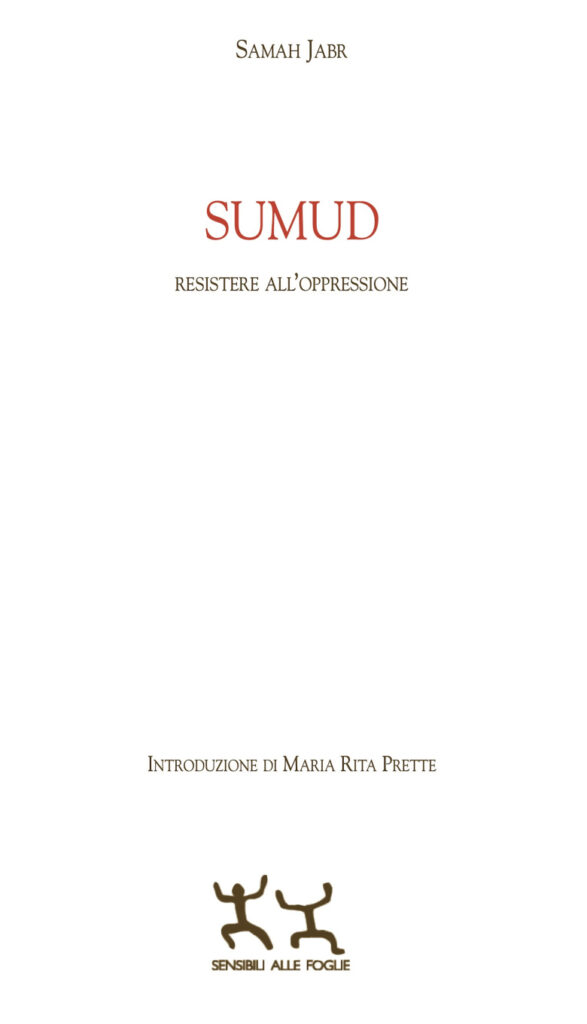
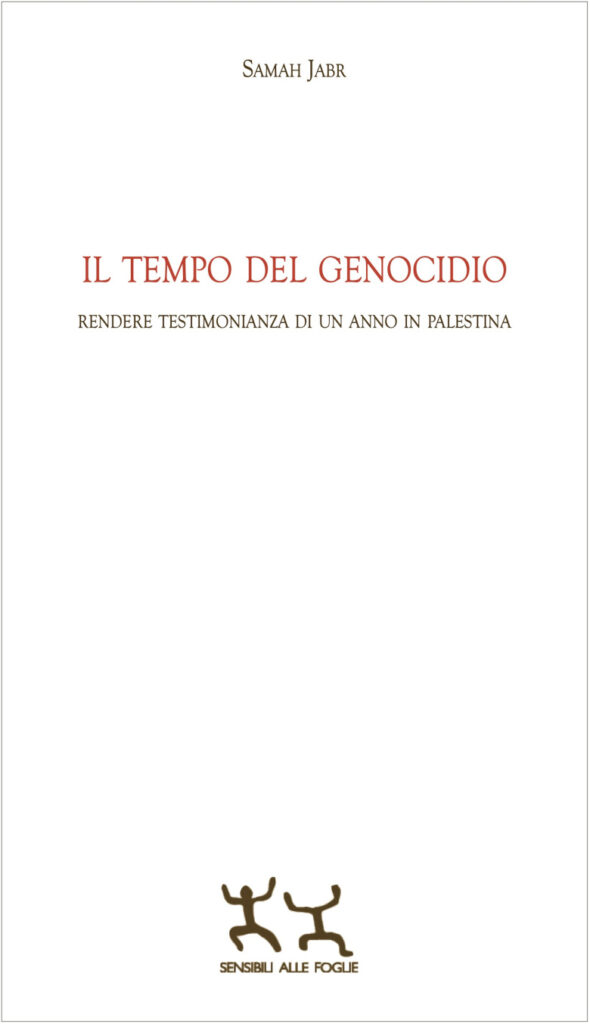
MN: Oltre che terapeuta lei è autrice di svariati libri e di molti articoli giornalistici. In Italia sono disponibili, pubblicate dalla casa editrice Sensibili alle foglie, tre piccole antologie dei suoi scritti: Dietro i fronti (2019), Sumud (2021) e Il tempo del genocidio (2024). Nell’ultimo, lei parla di “trauma vicario”, vale a dire di quel trauma che non si ferma alla persona che lo subisce direttamente, ma raggiunge anche chi ne legge o assiste alle sue conseguenze attraverso le immagini diffuse dai media, mainstream o social che siano.
SJ: Questa sua domanda mi permette di insistere sugli effetti terapeutici della solidarietà internazionale per i palestinesi. Come psichiatra, io credo nel potere curativo della solidarietà. I suoi benefici sono reciproci: arricchiscono e sanano sia chi dà sia chi riceve. La passività, l’apatia e l’indifferenza, la semplice incapacità o indisponibilità a prendere atto di una tragedia che, pur non colpendoci in prima persona, altera lo scenario in cui tutte e tutti viviamo, sono una malattia dello spirito.
Solidarizzando con i palestinesi, ci si impegna in un processo di guarigione collettiva dal senso di colpa e dall’impotenza legate proprio al trauma vicario, inteso come esposizione indiretta a un evento traumatico che colpisce altri. Basti pensare al lutto immenso, all’incredibile senso di disfatta, che stanno vivendo le persone, le associazioni e le istituzioni che hanno creduto nei diritti umani e per essi si sono battuti e continuano a battersi. In Palestina rischia di morire una visione del mondo.
MN: Che fare dunque, come direbbe Godard, ici et ailleurs?
SJ: Guardare, ascoltare, rispettare la complessità, non stancarsi di raccontare, essere umili, affidarsi alla sapienza di chi soffre, non aspettare le grandi soluzioni. Nella mia esperienza clinica ho verificato che per una madre che si è vista uccidere un figlio la vicinanza di altre madri che hanno attraversato lo stesso dolore è assai più efficace di qualsiasi mio intervento. Lo stupore pietrificato della depressione e del lutto può sciogliersi solo nell’abbraccio di un ‘noi’ amoroso e accogliente. Ricamare insieme, per esempio, è un gesto che libera la parola e induce all’ascolto reciproco, alla condivisione. Io non sono molto ispirata dalla teoria, preferisco l’empatia, una capacità che si può espandere solo attraverso l’esperienza.
MN: C’è, oggi, in Palestina una sofferenza specificamente femminile?
SJ: Sì, un forte senso di colpa, che nasce dall’incapacità di proteggere la vita dei propri figli. C’è una peculiare forma di depressione che colpisce in particolare le donne incinte o le puerpere: perché dare la vita a un figlio se non è dato vederli crescere o vedere riconosciuta la loro e nostra umanità?
Inoltre, in una società patriarcale quale è quella palestinese, l’implacabile demascolinizzazione degli uomini – incarcerati, disoccupati, umiliati, degradati nella loro immagine fisica – le espone a una duplice violenza e a un vissuto estremamente complesso di parentalità. La ricaduta sui figli bambini, spesso costretti ad assumere il ruolo genitoriale, è pesantissima.
MN: Lei è una figura pubblica estremamente esposta. Le capita di avere paura?
SJ: Da psichiatra e psicoterapeuta so che il prezzo del silenzio è troppo alto. Mi viene chiesto spesso: «Non temi di andare in prigione per il fatto che parli e scrivi?». Oppure: «Ma il fatto stesso che tu sia qui e possa parlare, non è la prova che Israele è una vera democrazia?».
Parlo, perché non posso fare altrimenti. Non posso fingere di non sapere. Nel mio lavoro ho visto pazienti ipocondriaci che si comportavano come se fossero malati per paura di ammalarsi. Nella mia vita quotidiana incontro persone che vivono come poveri per paura della povertà. Ho visto persone che non sono in grado di comunicare nelle loro relazioni per paura dell’abbandono. Non voglio perdere le mie opportunità, come hanno fatto queste persone, e vivere rinchiusa nella mia mente, per paura di essere gettata dietro le vere sbarre di una prigione. Non nego che ho questa paura, ma preferisco affrontarla ed esprimermi, costi quel che costi.
Fonte: Doppiozero



